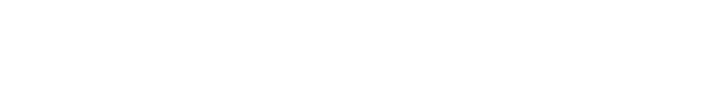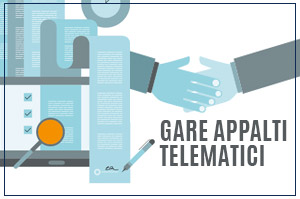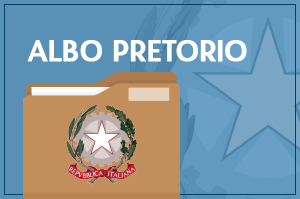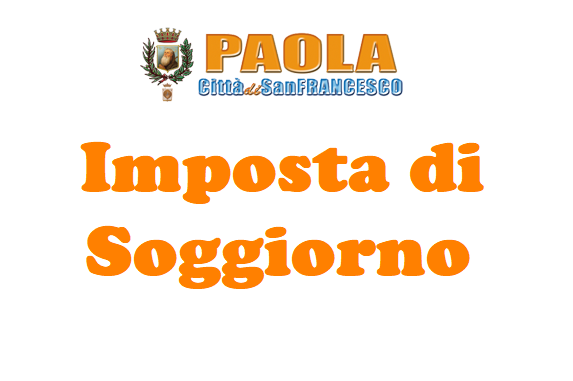Curiosità
CURIOSITA'
Curiosità, da sempre, significa cercare di sapere ed esaminare cose altrui per il gusto di conoscerne gli aspetti più intimi o per amore del pettegolezzo. Questa raccolta, anche se breve, è solo indicativa, per i vasti e articolati interessi della collettività, che spaziano dall'amore all'amicizia, dalla verità alla falsità, dalla bontà alla cattiveria, dal coraggio alla paura e via discorrendo, e che lasciano poco d'inesplorato tra i grandi scrittori del passato e del presente, tra gli uomini politici, gli scienziati, i teologi, i poeti, i filosofi, gli esploratori e gli antropologi.
Le curiosità, estrapolate da contenuti più estesi, sottolineano la spontanea individuazione del modo di essere e del vivere arcaico, e sono descritte, spesso, da uomini semplici, i quali ci aiutano a ricostruire la condizione dell'uomo nel suo arco temporale determinato. Esse sono state collezionate con grande libertà e fantasia, vaga e capricciosa, ma al tempo stesso corretta, certa e veritiera. Vi si trovano parole corpulente, detti crepitanti e pittoreschi, ma soprattutto cogitazioni originali e fresche che producono un ridente stupore, creando, scolpendo e colorando l' immagine sbiadita dal tempo. Fanno risaltare la grandezza epica dell'individuo, il suo dolore, il suo modo di essere, il tormento che l'accompagna, la bellezza del mondo, le verità del patire e dello sperare; elidono la disperazione e inducono all'accettazione della vita, comunque sempre degna di essere vissuta.
Questa raccolta è pertanto un microscopico rendiconto di una cultura, dai tempi illimitati, che ci guida intelligentemente nella storia; ci consente una riflessione, un termine di paragone, tutta echeggiante di antichi e moderni accenti, in forme duttili e articolate che scandiscono l'esigenza di un costante dialogo che sia finalizzato alla mutua comprensione di noi stessi. Nel vivere e nell'operare non ci devono essere limiti o barriere per l'uomo, essendo affidata alla sua iniziativa la promozione del suo sviluppo, nella cognizione che dopo ogni azione egli riesce a tonificarsi, tanto in positivo come in negativo. Questo sito Web, tanto ricco d'interessi, è pieno di curiosità, notizie originali, che vanno dal giuoco di parole al nonsenso, dal ritrattino all'aneddoto, dal giudizio ironico, a volte maligno, al paradosso, dal raccontino-lampo allo sberleffo parodistico.
Attrezzi da pesca:
"A Minàita". Questa rete veniva adoperata solo per la pesca del pesce azzurro.
"A Cannizzòla-Catrizzola". Essa era formata da fascine o da canne e veniva portata al largo per essere adagiata sul mare durante il passaggio dei tonni e delle ricciole.
I pesci, per ripararsi dal sole, si nascondevano sotto di essa e, dopo un pò di tempo, i marinai calavano una rete tutta intorno per imprigionarli. Essa, successivamente, veniva tirata a riva.
Fuochi "pi ronnini ri mare". Nelle serate di Agosto veniva acceso un grosso falò sulla riva in modo che i pesci rondine, attratti dal bagliore del fuoco, si lanciassero verso di esso e rimanessero a secco sulla riva.
"`U Lanzatùri". Era una fiocina lunga dai 5 ai 6 metri che veniva scagliata addosso ai pesci per infilzarli. Per fare questa pesca era necessario costruirsi una scatola col fondo di vetro per vedere meglio i pesci in profondità.
"Sciabica e Sciabbachiddu". Era una rete di circa 500 m. "sciabica" e 100 "sciabbachiddu", a maglie di diverse grandezza, che galleggiava in superficie; al centro di essa c'era "lu cuppi", una sorta di grosso sacco a maglia strettissima. Un capo dell' intreccio veniva tenuto a riva, mentre la rete veniva filata in mare in senso circolare; in seguito l'altro capo veniva portato a riva. Con forza, l'attrezzo veniva tirato da riva da ambo i lati, convergendo sempre al centro. Lo "sciabbacchiddu è ancora usato per la pesca della "rosamarina" (neonata-bianchetto).
La flotta peschereccia. Nel 1854 era composta da 23 bastimenti, di cui 16 barche, 3 gozzi, 2 feluconi, i mistico e i bove per complessive 234 tonnellate di stazza. Questi pescherecci venivano adoperati per la pesca dei tonni che poi venivano lavorati nella contrada Tonnara. (ancora oggi la zona si chiama con tale nome).
Gastronomia. L'espressione "fuoco sopra e fuoco sotto" deriva dall'uso di porre le braci sul coperchio del tegame, quando non era disponibile il forno.
Info
Servizi Online
ORGANI DI GOVERNO
IL SINDACO L'attuale Sindaco è Giovanni Politano, nato a Belveder ...
CONSIGLIERI COMUNALI: Giovanni POLITANO - Sindaco Renato VILARDI Marco MINERVIN ...
DELEGHE ASSESSORI COMUNALI ASSESSORE - VICE SINDACO Maria Pia Serran ...